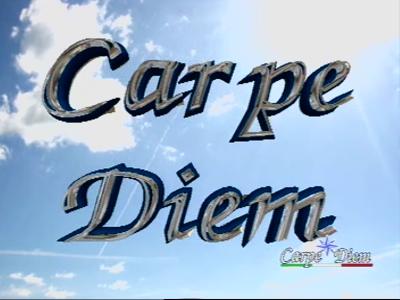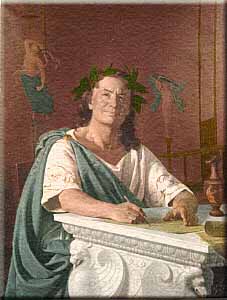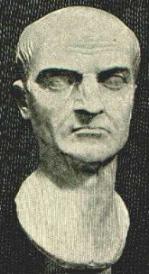E' un dramma crepuscolare, dominato dalla persistenza della penombra e della notte.
A questa caratteristica nei toni,corrisponde la negatività dei temi, che trattano dei morti, del suicidio, della disperazione, della pazzia ,della vendetta del sangue.La stessa struttura dell'opera è labirintica, costruita apposta per produrre un senso di smarrimento simile a aquello che invade i protagonisti mentre osservano il proliferare del male dentro di loro.
In realtà si tratta di storie diverse che si intrecciano( quella di Amleto , ma anche le altre di Ofelia, di Claudio, di Gertrude, di Laerte) ciascuna delle quali può costruire l'inizio di un'ulteriore vicenda, o ,comunque ,un punto di osservazione alternativo. rispetto a quello del protagonista, da cui giudicare il progredire della vicenda.
La contiguità di queste storie è rinsaldata dalla comune presenza di un destino di morte, che si manifesta nelle parole più che negli atti.Le radici della tragedia, restano fuori della tragedia ,si annidano ,infatti ,nella coscienza, nella memoria, nei sospetti dei protagonisti ed esplodono in tutta la loro violenza soltanto nel sanguinoso finale.Più di quanto si vede , è importante quello che si nasconde nei cuori , dove incontenibile cresce il male.
La tragedia può essere divisa in quattro fasi.
Nella prima (corrispondente al primo atto)il fantasma del re di Danimarca , Amleto, compare dinanzi al figlio che porta il suo stesso nome.E' notte fonda e l'incontro avviene sulle mura del castello di Elsinore, sotto lo sguardo incredulo di alcune guardie fidate(Bernardo,Marcello e l'amico Orazio).Egli è stato assassinato per mezzo di un veleno versatogli nell'orecchio durante il sonno del fratello Claudio, che ha poi sposato la vedova Gertrude ed ereditato il trono. Adesso il re chiede al figlio vendetta e, al tempo stesso, pietà per Gertrude , sua madre.Il giovane Amleto giura obbedienza e, ottenuta una promessa di silenzio circa l'accaduto da parte degli altri testimoni,si finge pazzo per ordire meglio il suo piano.Il suo strano comportamento viene attribuito per lo più all'amore per Ofelia,figlia del ciambellano Polonio, alla quale in passato egli ha manfestato il proprio sentimento, ma che ora tratta con durezza.
La seconda fase (atto secondo e atto terzo, scena prima)si apre con il ripudio di Ofelia,preceduto dalla recita del famoso monologo da parte del protagonista. La presenza nel castello di una compagnia teatrale gli offre l'occasione per mettere in scena l'episodio dell'uccisione del padre, in modo da verificare se le reazioni dello zio ne provano la colpevolezza(è un esempio di teatro nel teatro , cioè di un'opera teatrale al cui interno si svolge un'altra rappresentazione). Il comportamento di Claudio tradisce la sua responsabilità , ma così anch'egli comprende che Amleto sa tutto e inizia a tramare contro di lui.
La terza fase ( fine atto terzo e atto quarto)è l'uccisione di Polonio per mano di Amleto, il quale lo colpisce scambiandolo per Claudio.
Si tratta di un tragico errore sufficiente per provocare la pazzia , in questo caso reale,di Ofelia , costretta a subire prima il ripudio di Amleto, poi l'assassinio del padre.Deciso a liberarsi di lui, Claudio lo invia in Inghilterra insieme a Rosencrantz e Guildenstern,che hanno ricevuto l'ordine di eliminarlo.La sorte vuole invece che i due periscano in mano dei pirati ee il principe,sfuggito al pericolo, rientri in patria.
Ha inizio la quarta fase ( atto quinto) .Al ritorno dall'Inghilterra, Amleto viene sapere che Ofelia si è uccisa e che il fratello di lei ,Laerte,è deciso a vendicare la morte sua e quella del padre.
I due si incontrano proprio durante il funerale della ragazza e si sfidano a duello, accettando però l'invito del re Claudio a misurarsi in uno scontro regolare.In realtà questi non solo ha munito Laerte di una spada con la punta avvelenata, ma per di più offre ada Amleto una coppa di vinoin cui è disciolta una sostanza mortale. E' l'epilogo.La morte cercata vicendevolmente travolge tutti i protagonisti: il veleno li colpisce uno dopo l'altro, per volontà o per errore.Cadono Laerte, Claudio, la stessa Gertrude e infine Amleto.Chiude la storia l'arrivo del principe Fortebracciodi Norvegia, che fa seppellire Amleto, rendendogli onore , e diventa il nuovo sovrano della Danimarca.Il ciclo di distruzione si placa quando la corona di Danimarca , conquistata con il sangue dal vecchio Amleto a spese del re Fortebraccio, torna sul capo di suo figlio, in virtù di un destino insondabile e cruento.
L'Amleto resta un'opera enigmatica, che conserva addirittura alcune incoerenze nell'assemblaggio degli episodi e delle situazioni, in parte dovute alla trasmissione del testo, che forse non fu mai definitivamente rivisto dall'autore. Esse investono lo stesso protagonista,che all'inizio viene presentato come un giovane studente dell'Università di Wittenberg e risulta invece avere trent'anni nell'atto quinto. Ma si tratta anche di conseguenze della sua struttura labirinticanella quale si riflette il travaglio interiore dei personaggi.
La personalità di Amleto
A questa caratteristica nei toni,corrisponde la negatività dei temi, che trattano dei morti, del suicidio, della disperazione, della pazzia ,della vendetta del sangue.La stessa struttura dell'opera è labirintica, costruita apposta per produrre un senso di smarrimento simile a aquello che invade i protagonisti mentre osservano il proliferare del male dentro di loro.
In realtà si tratta di storie diverse che si intrecciano( quella di Amleto , ma anche le altre di Ofelia, di Claudio, di Gertrude, di Laerte) ciascuna delle quali può costruire l'inizio di un'ulteriore vicenda, o ,comunque ,un punto di osservazione alternativo. rispetto a quello del protagonista, da cui giudicare il progredire della vicenda.
La contiguità di queste storie è rinsaldata dalla comune presenza di un destino di morte, che si manifesta nelle parole più che negli atti.Le radici della tragedia, restano fuori della tragedia ,si annidano ,infatti ,nella coscienza, nella memoria, nei sospetti dei protagonisti ed esplodono in tutta la loro violenza soltanto nel sanguinoso finale.Più di quanto si vede , è importante quello che si nasconde nei cuori , dove incontenibile cresce il male.
La tragedia può essere divisa in quattro fasi.
Nella prima (corrispondente al primo atto)il fantasma del re di Danimarca , Amleto, compare dinanzi al figlio che porta il suo stesso nome.E' notte fonda e l'incontro avviene sulle mura del castello di Elsinore, sotto lo sguardo incredulo di alcune guardie fidate(Bernardo,Marcello e l'amico Orazio).Egli è stato assassinato per mezzo di un veleno versatogli nell'orecchio durante il sonno del fratello Claudio, che ha poi sposato la vedova Gertrude ed ereditato il trono. Adesso il re chiede al figlio vendetta e, al tempo stesso, pietà per Gertrude , sua madre.Il giovane Amleto giura obbedienza e, ottenuta una promessa di silenzio circa l'accaduto da parte degli altri testimoni,si finge pazzo per ordire meglio il suo piano.Il suo strano comportamento viene attribuito per lo più all'amore per Ofelia,figlia del ciambellano Polonio, alla quale in passato egli ha manfestato il proprio sentimento, ma che ora tratta con durezza.
La seconda fase (atto secondo e atto terzo, scena prima)si apre con il ripudio di Ofelia,preceduto dalla recita del famoso monologo da parte del protagonista. La presenza nel castello di una compagnia teatrale gli offre l'occasione per mettere in scena l'episodio dell'uccisione del padre, in modo da verificare se le reazioni dello zio ne provano la colpevolezza(è un esempio di teatro nel teatro , cioè di un'opera teatrale al cui interno si svolge un'altra rappresentazione). Il comportamento di Claudio tradisce la sua responsabilità , ma così anch'egli comprende che Amleto sa tutto e inizia a tramare contro di lui.
La terza fase ( fine atto terzo e atto quarto)è l'uccisione di Polonio per mano di Amleto, il quale lo colpisce scambiandolo per Claudio.
Si tratta di un tragico errore sufficiente per provocare la pazzia , in questo caso reale,di Ofelia , costretta a subire prima il ripudio di Amleto, poi l'assassinio del padre.Deciso a liberarsi di lui, Claudio lo invia in Inghilterra insieme a Rosencrantz e Guildenstern,che hanno ricevuto l'ordine di eliminarlo.La sorte vuole invece che i due periscano in mano dei pirati ee il principe,sfuggito al pericolo, rientri in patria.
Ha inizio la quarta fase ( atto quinto) .Al ritorno dall'Inghilterra, Amleto viene sapere che Ofelia si è uccisa e che il fratello di lei ,Laerte,è deciso a vendicare la morte sua e quella del padre.
I due si incontrano proprio durante il funerale della ragazza e si sfidano a duello, accettando però l'invito del re Claudio a misurarsi in uno scontro regolare.In realtà questi non solo ha munito Laerte di una spada con la punta avvelenata, ma per di più offre ada Amleto una coppa di vinoin cui è disciolta una sostanza mortale. E' l'epilogo.La morte cercata vicendevolmente travolge tutti i protagonisti: il veleno li colpisce uno dopo l'altro, per volontà o per errore.Cadono Laerte, Claudio, la stessa Gertrude e infine Amleto.Chiude la storia l'arrivo del principe Fortebracciodi Norvegia, che fa seppellire Amleto, rendendogli onore , e diventa il nuovo sovrano della Danimarca.Il ciclo di distruzione si placa quando la corona di Danimarca , conquistata con il sangue dal vecchio Amleto a spese del re Fortebraccio, torna sul capo di suo figlio, in virtù di un destino insondabile e cruento.
L'Amleto resta un'opera enigmatica, che conserva addirittura alcune incoerenze nell'assemblaggio degli episodi e delle situazioni, in parte dovute alla trasmissione del testo, che forse non fu mai definitivamente rivisto dall'autore. Esse investono lo stesso protagonista,che all'inizio viene presentato come un giovane studente dell'Università di Wittenberg e risulta invece avere trent'anni nell'atto quinto. Ma si tratta anche di conseguenze della sua struttura labirinticanella quale si riflette il travaglio interiore dei personaggi.
La personalità di Amleto